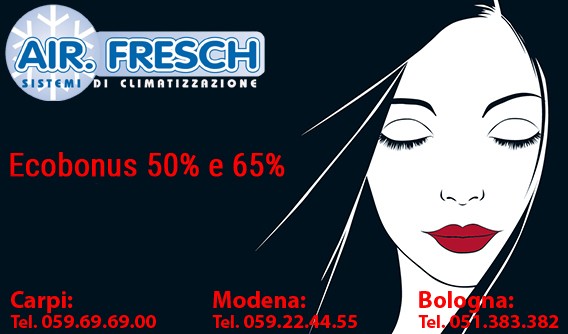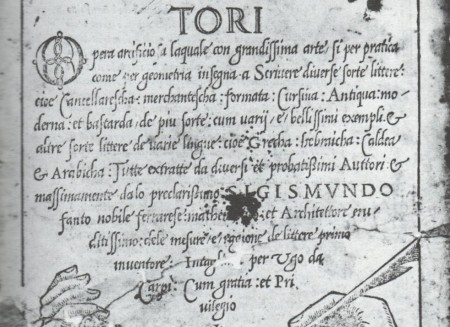A conclusione dell'anno celebrativo del centenario della nascita di don Nino Levratti, riproduciamo qui sotto il saggio che Gianfranco Imbeni dedicò al sacerdote, in occasione dell'uscita nel 2007 del suo libro “La nostra età fiorita ”. Il testo si trova nel volume “Di penna e di parole: all'incrocio di due millenni, tra Carpi e l'universo mondo”, edito nel 2020. Dove il titolo del saggio – “La nostra età fiorita: un oratorio nella storia” è accompagnato dal sottotitolo: “...del fantasma benigno della Riforma protestante nell'opera di don Nino Levratti e di altri sacerdoti, ciascuno con la propria personalità”.
Sapevamo già che fra i talenti di don Nino c'è anche una capacità di scrittura nutriente, nitida e distesa, accanto a quelli ben noti del grafico e disegnatore ricco di fantasia e di humour (tra lo Jacovitti e il Caesar del Vittorioso, per capirci) oltre al suo estro di documentarista cinematografico capace di far parlare le immagini con l'occhio di un regista, cioè di un narratore, che va ben al di là delle capacità dell'appassionato cinefilo.
Qualche anno fa don Nino ci aveva fatto pervenire insieme con una cassetta (un collage di filmine sulle avventure sue e dei suoi ragazzi, scout e giovani di Azione cattolica) una lettera di accompagnamento che commentava una nota apparsa in questa rubrica all'incirca sui medesimi argomenti ("Quando il prete è un vero signore", marzo 2001). Quella lettera personale la conserviamo con gratitudine per diverse intime ragioni, non ultima la squisitezza del suo valore letterario. E' la stessa qualità che ritroviamo anche in questo volume molto grosso, forse un po' troppo: 226 pagine pesanti e di grandi dimensioni ricche di illustrazioni a colori e in bianco e nero (don Nino Levratti, "La nostra età fiorita", giugno 2007, Editrice Il Portico) che ci trasmette i significati e le avventure di "un oratorio dal 1952 nel cuore della città di Carpi".
***
Al centro di un certo viluppo di vicende, "per tutto un complesso di cose" direbbe Paolo Conte, che ci legano in modo speciale a sentimenti, fatti e volti di questo libro, siamo grati all'autore di averlo scritto mosso non prevalentemente da un impulso da espressore (neologismo gaddiano impietoso verso l'imperversante corsa alla "creatività") bensì dall'intenzione, perfettamente riuscita, di mettere a disposizione del lettore la sua chiarezza sintetica, una dote di servizio che, per altro, ha sempre caratterizzato la sua stessa attività pastorale, specialmente nell'esercizio della liturgia della parola.
Facciamo un esempio. Tra i catechisti ritratti in una fotografia di gruppo appare don Azzo Cucconi, un prete che, se il ricordo non tradisce, era negli anni Cinquanta assistente ecclesiastico della Fuci, l'associazione universitaria cattolica. Su di lui, prematuramente scomparso alcuni anni fa, don Nino non spende soverchie parole. Ma discorrendo sul tema della catechesi (sulla sua scarsa diffusione nelle parrocchie, eccetera) dopo avercelo mostrato in immagine, ce lo ha fatto ricordare (ri-cor-dare, col cuore in mezzo) con la sua forza di dialogo, di colloquio, quando ci confidava: "Ciò di cui possiamo patire la mancanza noi sacerdoti non è in primis il sesso come molti pensano, ma la paternità". E ci faceva pensare alle esplosioni di un poeta come padre David Maria Turoldo quando scriveva: "Io non ho mani...", che mi accarezzino, o che io possa accarezzare impunemente. Anche se (per il nascondimento fino alla sparizione a cui la malattia lo costringeva) don Azzo era più vicino a un don Clemente Rebora, non perché fosse passato attraverso la conversione ma per il ritmo della sua meditazione, rarefatta e sconvolgente, e per quella sua consunzione lenta, misteriosa, trasudante stille di amore per il prossimo e per la verità.
Padre David Turoldo, che fu anche attivo nei tempi più duri della Nomadelfia di Fossoli, e che l'arcivescovo Giovanni Battista Montini chiamò in cattedrale a predicare alla buona borghesia milanese con quella sua voce baritonale da protodiacono, era un apostolo la cui testimonianza sfidava i confini della rappresentazione sacra medievale con tutto quanto di plateale ne conseguiva, come fu anche, appunto, per don Zeno Saltini. E come è stato per numerosi sacerdoti della nostra diocesi: Vincenzo Benatti, per il genio imprenditoriale di creatore dell'Aceg, un acrostico che spazzava via il tanfo d'incenso delle sagrestie dai suoi propositi manageriali. E come è per don Ivo Silingardi il quale stupisce ancora i bipedi carpensi per l'attivismo vincente e senza sosta, quasi una ubiquità da Sant'Antonio finalizzata a non si sa che cosa, forse a una fuga senza fine dall'ignavia. Poi don Sergio Galli forse più serafico ma meno cherubinico, il "parroco del lavoro" all'epoca del boom economico, che precedette don Levratti alla direzione dell'oratorio nel biennio 1952-1954, uomo sempre in movimento che scovava posti di lavoro anche per chi non glieli richiedeva. E l'adorabile ma troppo facilmente accostabile don Donato Battaglia, creatore di un discusso istituto di "Protezione della giovane" in epoca tossicheggiante, martoriato nelle membra e nell'anima. E altri preti, ciascuno con una propria personalità forte e ben distinguibile ma tutti come dannati a una costante visibilità che talvolta essi stessi contribuivano ad alimentare. Tutti, lo diciamo col senno di poi, legati a un ruolo specifico, preciso, determinato, nessuno di loro pensoso o dubitoso se pure potesse esistere un varco.
Nessuna sovraesposizione in don Nino Levratti, il quale invece ci appare attuale, moderno, cioè propositivo e produttivo, e all'altezza dei tempi, nelle azioni pionieristiche di sessant'anni fa come nei paragrafi che abbiamo delibato commossi in questo suo prezioso lavoro letterario.
Guardando questa cosa di chiesa da un'angolazione certamente restrittiva e un po' obliqua ma fedele alla memoria, l'attualità di don Nino la ravvisiamo soprattutto nella sua volontà e nel suo talento nel "fare parrocchia". Quel campo dell'Eden, che nel dopoguerra si chiamava "di don Benatti", con i suoi vasti spazi chiostrali collegati, al chiuso e all'aperto, costituiva rispetto ad altre più modeste realtà parrocchiali la testimonianza, la prova concreta di una visione più complessiva, più alta, di quell'unica "educazione sentimentale" collettiva che i Carpigiani hanno conosciuto. Una educazione che si sviluppava nel segno della fede nell'imperscrutabile, o perlomeno in quel "sentimento di religiosità che alberga in ogni cuore cittadino" come era solito concludere sbrigativamente il don Silingardi di cui sopra.
Ed è curioso che a inventare e a condurre per tanti decenni un movimento giovanile di così vasto e profondo respiro "popolare" sia stato un convinto seguace del generale inglese Baden-Powell, un presbitero, don Levratti, che nei modi come forse nel suo sentire profondo, offre una perfetta immagine di understatement che più english non si può. Si direbbe che il fantasma benigno della riforma protestante si aggiri sopra la nostra più tradizionale e riuscita forma di aggregazione educativa e sociale. Che ancora resiste e anzi in questi mesi mostra segni di rinascita anche in taluna di quelle parrocchie che, per tanto tempo, tra sagre "inventate" (Madonne "delle rose" e santi Bernardini a cui non si rivolge nessuno) e scoppiettìi di iniziative da festa dell'Unità, se ne sono rimaste tranquillamente inattive. Il sabato e la domenica, e nelle altre feste comandate, solo le squadriglie scout animano i cortili delle canoniche, una "giovanezza" che "non vien meno".
***
Il leopardiano "Sabato del villaggio", canzone fuori da ogni schema metrico ma con magnifici ricorsi alla rima al mezzo, è posta dall'autore in esergo al volumone ai versi 44-48 che qui riportiamo perché l'editor, o chi per lui, è riuscito ad accumulare cinque errori di trascrizione in sole sei righe, oltre all'indebita frantumazione di due endecasillabi: "...cotesta età fiorita / è come un giorno d'allegrezza pieno, / giorno chiaro, sereno, / che precorre alla festa di tua vita". L'eco di questi versi raggiunge le penultime righe dell'Introduzione ("Ritorno alle radici") scritta da don Nino: "Fatico a comprendere le persone senza speranza. Penso al vuoto di senso che li accompagna. Tuttavia, mi sono reso conto dell'abisso che esiste, talvolta, tra gli ideali sognati nelle prime stagioni della vita e la realtà vissuta e condizionata da esperienze imprevedibili". Il pessimismo "cosmico" del Leopardi sembra contraddire il don Nino oratoriale quando dice: "La fede che il Signore mi ha donato mi permette di essere ostinatamente ottimista", e poi ricongiungervisi quando alla fine esorta "a vivere, con saggezza, i giorni nostri che ancora 'sono sotto il sole' (Qoelet)". E' propriamente quanto ha fatto Giacomo Leopardi per l'intero arco della sua breve età adulta, la sua "festa" che non aveva certo tardato "a venir", la quale segnò la fine delle illusioni, ma anche l'inizio della luminosa stagione della "Ginestra, o il fiore del deserto" un canto stupendo, una preghiera laica, che anche lui fece precedere da una citazione biblica: "E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce" (Giovanni, III, 19).
Gli stessi umani che si aggrappano anche oggi a "superbe fole", le fedi religiose e gli idealismi progressivi, le une e gli altri fondati sul principio illusorio e pernicioso che l'uomo sia padrone e signore, centro e fine dell'universo. Con tutti i guai, i crimini, i disastri che abbiamo sotto gli occhi.